L’ozio coatto del campo di concentramento
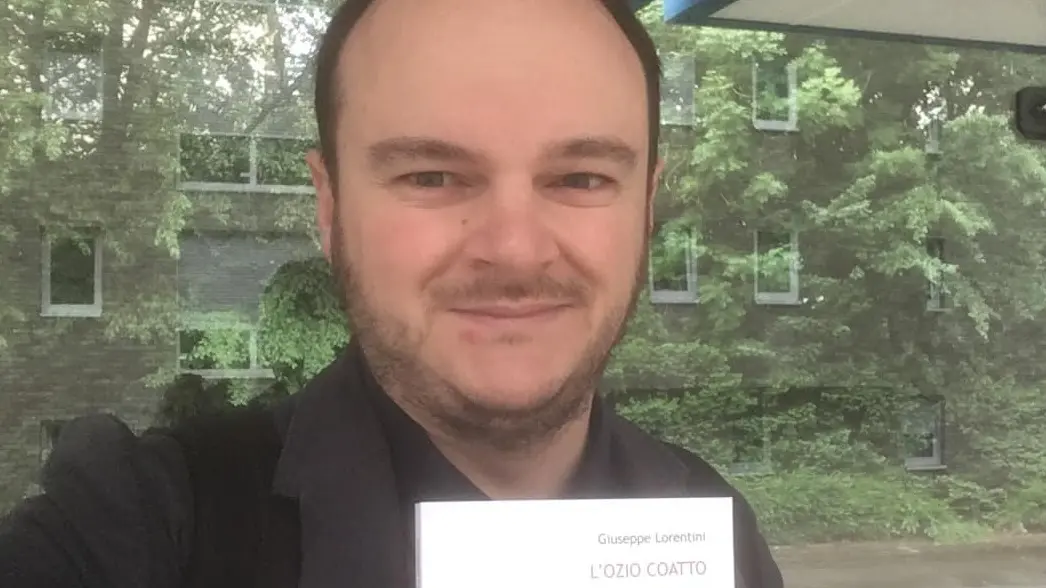
Il ricercatore abruzzese Giuseppe Lorentini racconta in un libro gli internati di Palazzo Tilli a Casoli durante la guerra
CASOLI. Gli internati ebrei e slavi nel Palazzo Tilli di Casoli sono adesso ricordati anche in un libro, "L'ozio coatto", che il giovane ricercatore casolano Giuseppe Lorentini dell'Università tedesca di Bielefeld ha pubblicato da pochi giorni con l'editore Ombre corte di Verona. Lorentini affronta l'intera problematica dell' «universo concentrazionario fascista» basandosi su una bibliografia sterminata italiana e straniera, da Capogreco a Di Sante, De Felice, Sarfatti, Voigt, passando per gli abruzzesi Gianni Orecchioni (autore de "I sassi e le ombre"), Nicola Palombaro ed anche Daniela Spadaro per il piccolo campo di Lama dei Peligni. I "campi del duce" furono 19 in Abruzzo e Molise, 48 in Italia, dislocati in gran parte nel Centro-sud, soprattutto in paesi montani, lontani dalle grandi vie di comunicazione, come appunto Casoli e Lama. L'autore fa anche una differenza tra campi di internamento, di concentramento e di sterminio, e fa risalire l'origine dei campi di concentramento per civili a Cuba, occupata dagli spagnoli, nel 1896.
Casoli ospitò dapprima 108 "ebrei stranieri" (gran parte polacchi rifugiatisi a Trieste), e poi 110 "politici antifascisti" iugoslavi (croati, sloveni, bosniaci). Dalla documentazione reperibile anche sul sito campocasoli.org curato dallo stesso Lorentini, viene fuori un quadro di umanità "dolente", isolata dal resto della popolazione, eccetto per alcuni casi, soprattutto ebrei un po' benestanti che potevano permettersi il pranzo nelle tre trattorie del paese.
Uno di loro tornò a Casoli nel dopoguerra per sposare la ragazza inserviente della trattoria. E' l' ozio coatto, come scrive un internato alle autorità chiedendo di poter svolgere un qualsiasi lavoro al di fuori delle mura del campo, ciò che gli viene prontamente negato. Una vita dura, che vietava ad un affermato medico urologo sloveno, Hermann Datyner, di prestare le sue cure alla popolazione per una lettera anonima di «tre fascisti del '19» in difesa del "vero popolo fascista". Datyner fu ucciso dai tedeschi al suo ritorno in Slovenia, e un ospedale porta il suo nome a Lubiana. Si può leggere una disperata lettera d'amore di una ragazza croata, Zara, al suo amato Ante che viene tenuto all'oscuro della missiva perché scritta in sebo-croato.
Ma la sorte peggiore toccò a dieci ebrei che da Casoli furono trasferiti in altri campi e poi spediti in quelli di sterminio da cui non fecero più ritorno. Come quel Giacomo Nagler, triestino di origine galiziana, strappato dalla sua Rita Rosani, partigiana uccisa dai fascisti di Salò in Veneto, il quale rifiutò di scappare per non lasciare solo suo padre. Storia raccontata da Livio Sirovich in un appassionante saggio romanzato da cui Lorentini ha preso spunto per la sua ricerca negli archivi comunali di Casoli, diventata oggi un libro che sarà presentato, oggi pomeriggio, nel Palazzo Tilli da Manuele Gianfrancesco, storico di Roma,Vincenza Iossa, bibliotecaria alla "Luigi De Gregosrio" del Miur, Stefania Laffin dell'Università di Bielefeld, con i saluti della proprietaria del Palazzo Tilli, Antonella Allegrino, del sindaco Massimo Tiberini e del presidente della provincia di Chieti Mario Pupillo, coordinati da Maria Rosaria La Morgia.
Il lungo e faticoso lavoro di Lorentini è un omaggio alla "memoria dimenticata", ed uno schiaffo all'indifferenza di ieri e al qualunquismo di oggi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA



