L’intervista a Michele Vietti: «Quella riforma del diritto societario è ancora un modello»
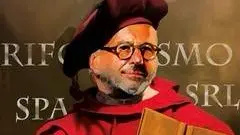
Ex Dc, avvocato, membro del Csm e professore straordinario, dal 2011, di Diritto delle Società alla facoltà di Scienze Giuridiche della UNINT di Roma è il papà del testo: «Fu un parto difficile, ma ha aggiornato le norme dopo 60 anni»
Presidente Vietti, oggi festeggiamo i vent’anni della riforma del diritto societario che porta il suo nome. Come si sente?
Benissimo. Pensi che bello: ho festeggiato anche il primo decennale, ma ora sono come un padre che porta una figlia alla laurea.
Come la raccontiamo la differenza tra il prima e il dopo-riforma?
Senta, lei ha presente l’Aprilia?
Certo che la conosco: una meravigliosa macchina d’epoca della Lancia.
La descriva.
Una berlina a forma bombata che ricorda vagamente il Maggiolino, ma molto più lussuosa, più potente e con cinque porte.
Ecco, proprio così. Immagini ora che nel 2001, quando iniziò il lavoro, noi in Italia avevamo un codice del diritto societario che era come l’Aprilia.
Ovvero? Bello ma datato?
(Sorride) Esatto. Viaggiavamo su una macchina lussuosa, ma progettata negli anni Trenta, senza servosterzo, e con gli standard di sicurezza degli anni Quaranta.
Parla ancora del Codice?
Sì. Il nostro codice civile era del 1942, ed era stato scritto al meglio, dai più bravi giuristi, con un grandissimo lavoro di squadra. Ma nel 2000 era già vecchio di un secolo!
Non potevi competere con gli altri Paesi.
Impossibile. Sarebbe stato difficile vendere delle Aprilia negli anni Duemila. Il nostro codice aveva retto molto bene, ma parlava di un’altra Italia.
Quale?
Quella del Regime: l’idea di uno Stato onnipresente, un mondo economico che esisteva solo nel perimetro di una economia dirigista.
Quale era il limite più grande?
Avevamo un unico format, un unico modello utilizzabile. La Società per azioni.
La Spa era l’Aurelia?
Esatto: poi volendo c’era una utilitaria, l’Srl, ma era come se non avesse le ruote. Eravamo la settima potenza del mondo, ma non avevamo flessibilità di modelli.
Pare incredibile che non ci fossero state riforme, prima.
Vero. Utilizzammo come base un lavoro preparatorio fatto dal mio predecessore, Piero Fassino. Molti anni di studi, seminari, ma non si era mai approdato a nulla di concreto.
Michele Vietti, 71 anni, almeno tre vite alle spalle: avvocato e politico nella prima repubblica, uomo di governo della seconda, vicepresidente del Csm nella terza. Ha inventato e realizzato (ieri) una utilissima cerimonia civile: il compleanno della riforma del 2024: «È come fare un bilancio. Se parliamo di macchine è un tagliando. Utile per mettere il risultato a disposizione di chi deve fare le riforme di domani”.
Partiamo da quel Vietti dei primi anni Duemila? Ex democristiano sabaudo, approdato in Parlamento nel 1994 con il centrodestra. Che politico era?
(Altro sorriso). Un giovane di belle speranze incredibilmente motivato a fare, e a far bene. Inconsapevole della difficoltà enorme. Forse o proprio per questo, malgrado i pronostici, riuscii.
Era davvero così difficile?
(Sospiro) Qualcuno mi guardava come un matto. Pensi: 1882 nasce il codice commerciale del Regno, 1942, il codice civile del Regime, nel 2002 inizio a lavorare alla riforma. Mi facevo coraggio dicendomi che, se va bene, ogni sessant’anni l’Italia produce una riforma.
Ah ah ah.
Ma qualcosa mi aiutava. I peccati della globalizzazione avevano riscritto le regole del mondo: la concorrenza diventava planetaria.
E i mercati conoscono i codici?
Certo: devono misurarsi con le condizioni ordinamentali delle nazioni. Potevamo essere competitivi con l’Aprilia? Forse a qualche collezionista delle auto storiche poteva interessare, ma a quell’Italia serviva una nuova motorizzazione.
La riforma nacque perché il clima era propizio?
(Scuote il capo) Mah… mica tanto propizio. Semmai il contrario.
In che senso?
Castelli era ministro della giustizia e io il suo sottosegretario. Mi assegnò la riforma forse perché era convinto che fallissi.
Sadico?
No, realista. Lo stato d’animo del ministro era riassumibile così: “Facciamola gestire a Vietti: tanto non si farà mai!”.
Ah ah ah.
Non ho le prove. Ma capita.
Lei però sa che dicevano: la riforma serve per salvare Berlusconi dai suoi processi per falso in bilancio.
E infatti questo non mi aiutava per nulla: sia perché l’opposizione era sulle barricate. Sia perché probabilmente qualcuno in cuor suo pensava: Facciamo la modifica del falso in bilancio e basta.
Ed era giusto abolire il reato?
Sì, a prescindere dai processi del Cavaliere.
Perché?
Era un grimaldello con cui i magistrati aprivano la porta delle inchieste: poi arrivavano tutti i reati a cascata.
Esempio?
Prima del concetto di “Alterazione sensibile” dei bilanci anche le banali sviste formali venivano contestate come reato. Faticammo a trovare la misura giusta, ma solo ora posso dire che ci riuscimmo.
Insomma, in quei giorni non era facile trovare la quadra.
È vero, in parte Berlusconi si avvantaggiava dell’abolizione del falso in bilancio. Ma era molto più grande l’obiettivo di una riforma di tutto il diritto societario.
Altre difficoltà?
Una enorme: Tremonti aveva dichiarato guerra alle cooperative, e la riforma toccava le loro specificità garantite dal codice del 1942.
C’erano precedenti?
Uno solo. L’unica riforma del codice civile era stata quella del diritto di famiglia, introdotto nel 1975.
C’era una differenza importante: quella riforma era stata imposta dalla vittoria del referendum sul Divorzio.
Non era stata la politica a scegliere i tempi, li avevano dettati gli elettori con il successo dei divorzisti contro il tentativo di abrogazione.
E come cambiò il paradigma?
Sul piano teorico, diciamo così, la nostra riforma Riconosceva il valore dell’autonomia del privato.
Qual era lo strumento?
Ricorda l’utilitaria? La riforma delle Srl creava un altro modello: queste aziende diventavano una sorta di società di persone a responsabilità limitata molto flessibile.
Una scarpa per tutti.
Esatto. Era il modello che mancava.
Non mi dica che avevate previsto tutto quello che è poi accaduto.
(Ride ancora) No, sarei bugiardo. Noi – per esempio – volevamo far allargare le società. Spingere le Srl verso l’alto, come dimensioni, avvicinandoci agli standard europei.
E invece?
Si moltiplicarono e proliferarono società su misura. Tante utilitarie adatte alla realtà italiana.
Altri effetti?
La riforma spingeva verso la società aperta, verso il ricorso al capitale di rischio. Nel 1942 questo era fantascienza.
Molte società di persone sono diventate Srl.
Anche grazie alla Flessibilità degli statuti societari. Sa come lo spiego ai miei studenti?
Me lo dica.
Abbiamo detto agli imprenditori: puoi scegliere la società che ti serve di più. Era come se prima, nel supermercato del diritto, ci fosse solo il ripiano di un prodotto surgelato.
E dopo la riforma?
Entravi, prendevi gli ingredienti e ti facevi la pizza come volevi tu.
C’era altro.
Le Governances alternative: il sistema dualistico che avevamo disegnato produsse effetti enormi, ad esempio nel sistema bancario.
Perché?
Senza questo modello forse non sarebbero nate le grandi aggregazioni delle banche. È un dato di fatto che le fusioni importanti sono avvenute facendo ricorso ai ruoli societari raddoppiati.
Intesa-San Paolo? Mediobanca?
La governance doppia venne scelta per le grandi fusioni. Costruito il nuovo modello dell’auto arrivava il compratore.
Un’altra cosa imprevedibile? Pensavamo di spingere verso la quotazione in Borsa, portare agli esami di maturità delle aziende.
E invece avete fatto proliferare le Srl.
Già. Perché la quotazione è un incubo.
Un salto troppo complesso?
Ecco un dato clamoroso: le società invece di quotarsi si “delistano”.
Cioè si cancellano e se ne vanno.
Infatti. Ed ecco perché questa riflessione è importante. Oggi è troppo complicato e costoso quotarsi.
Perché le società quotate non le avete toccate.
Un paradosso; era stato già fatto con la legge Draghi del 1998.
Altre cose utili?
La possibilità di creare un patrimonio separato, dedicato ad un obiettivo, senza dover fare una nuova società.
Lo ha fatto Poste.
E tanti altri.
La vostra riforma ha favorito la riforma del diritto fallimentare.
Certo! Prima rispondevi di tutto. Ti venivano a prendere a casa! Noi favorimmo la prima riforma del diritto fallimentare, i concordati tra creditori e fallito, la fine di quella idea che se fallisci sei un criminale.
Anche questo era un cambio di paradigma.
Introducevamo il concetto che il fallito non è un reprobo. E che la liquidazione non è una dramma.
Perché?
Non è lo Stato che decide come si fa lo spezzatino a suo piacimento. C’è un commissario e il concordato preventivo in continuità evita il fallimento.
La legge delega fu votata solo dal centrodestra.
Vero. Ma i decreti legislativi passarono in commissione. Parere favorevole all’unanimità.
E sulle coop come finì?
Riuscii a scrivere le norme in modo da garantire tutti. Sciolsi il nodo della cosiddetta mutualità prevalente.
Ovvero?
Puoi avere la governance cooperativa anche senza avere agevolazioni fiscali.
E in cambio?
Le Coop vere accedevano a tutte le forme agevolate e anche agli strumenti del diritto societario.
È vero che anche a destra qualcuno storse il naso?
Sì. Per la norma sui grandi gruppi. La capogruppo risponde dei danni arrecati ai soci e ai creditori dalla controllante. È una norma di civiltà.
È invecchiata questa… ragazza?
Al contrario. Vent’anni e non li dimostra. Le Regole limitate al necessario: per il resto libertà. La trasparenza come opportunità.
E la Borsa?
Ecco il tema: tutti scappano dalla Borsa italiana: meno 130 miliardi di euro in dieci anni.
Eppure proprio oggi il governo ha approvato il primo decreto di modifica del Tuf, il Testo unico di finanza.
Ecco cosa mi sta a cuore. Nessuno lo ha letto. Un testo redatto nelle catacombe. Se vogliono fare una riforma copino almeno questo.
Cioè?
Non si può cambiare nulla senza un grande dibattito pubblico tra i soggetti interessati!
©RIPRODUZIONE RISERVATA



