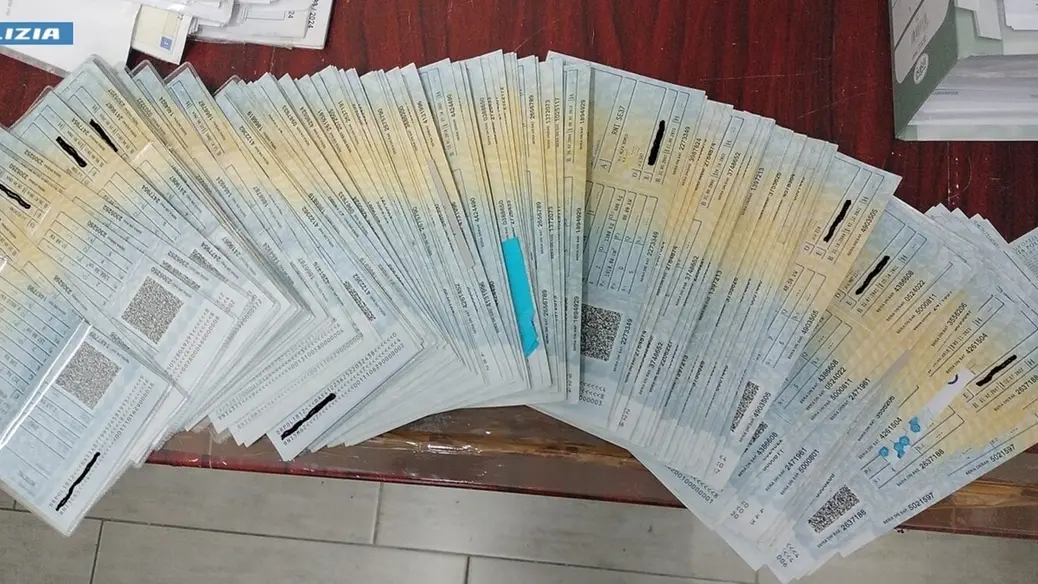Lama dei Peligni, un abitante su dieci è stranieroL'integrazione diventa realtà sotto la Maiella

Il comune primo nel Chietino per numero di forestieri: 129 su 1.407 abitanti, il 9% della popolazione. Vengono dall'est Europa e dal sudamerica e qui trovano lavoro e guardano al domani con speranza. Dal 1997 c'è una scuola di italiano per stranieri, ma l'integrazione è cominciata anni prima: "Nel 1991 abbiamo avuto una bimba romena, all'epoca extracomunitaria che poi è riuscita a laurearsi con 110 e lode"
LAMA DEI PELIGNI. Alfonc, 32 anni, è l'unico elettricista-artigiano di Lama dei Peligni, il paese dei camosci tra il fiume Aventino e le falde del Parco della Maiella. E' nato in Albania, a Tirana, ma qui in poco tempo è diventato come il Manny tuttofare della Disney che ripara ogni cosa. E visto che tutti lo chiamano Alfonso, Alfonc ha chiesto al prefetto di cambiare nome: per chi lo cerca lui è Alfonso, punto. C'è pure che per gli italiani il nome Alfonc, senza lettere finali nella lingua d'origine, suona strano fino a rievocare i modelli delle auto straniere di una volta come la Kadett o la Escort con la sagoma goffa e un po' rustica, di moda soprattutto tra gli emigrati in Svizzera e in Germania. E allora via il passato e spazio al presente guardando a un domani speranzoso. E Alfonso, che qui è ha messo piede quando aveva 11 anni, a ragion veduta ha detto che sì, è giunto il momento di completare la sua metamorfosi da albanese a italiano rimodellando una delle essenze della sua identità: il nome.
Una storia, una infinità di storie in questo paese al primo posto nella provincia di Chieti per numero di stranieri: 129 su 1.407 abitanti, il 9% della popolazione. Prima ci sono i romeni, poi i serbi e quindi gli albanesi come Alfonso, arrivato a marzo del '91 con papà, mamma e sorella. «In Albania non si poteva più viveve per i disordini sociali», racconta Vollca Rrushhulli, 53 anni, madre di Alfonso, «ricordo lo sbarco a Brindisi e l'aiuto della Caritas, mio marito che acciaccava un po' d'italiano perché vedeva in tivù i canali italiani. Ma ricordo soprattutto padre Salvatore, frate del convento di Lama: è stato un papà, si è preso cura di noi e ci ha fatto restare. Sono passati 20 anni», continua Vollca, «e a Lama stiamo benissimo. Alfonso si è fidanzato; la sorella di 29 anni è parrucchiera sposata a Torricella Peligna con un meccanico; mio marito Shaban è operaio in Val di Sangro. Anch'io ho lavorato e ora sono nonna a tempo pieno con due nipoti. Abbiamo comprato la casa qui: la gente è accogliente e ho tante amiche. Tornando indietro rifarei la stessa scelta». Vollca si è talmente integrata che oltre a parlare il dialetto fa cucina solo locale: «sagne e fasciule, pallotte casce e ove, pizza e fojje», spiega «e pure la sfogliatella di Lama», il dolce napoletano con l'aggiunta di strutto, noci, marmellata di uve Montepulciano e di amarene, diventato la tipicità del paese. «Una bontà», conclude Vollca puntando l'indice della mano sulla guancia e avvitandolo con uno scatto.
Florina Ionescu Vasilica, invece, ha 31 anni e viene dalla Romania. E' stata prima a Palena e poi a Lama: otto anni in tutto. «Quando sono arrivata», spiega Florina, «ho fatto la badante per sei mesi, poi la baby-sitter. Mi sono trasferita a Lama e per sette anni ho lavorato come falegname. Qui ho incontrato gente brava e ospitale che mi ha aiutato nei momenti difficili. Non conoscevo mezza parola in italiano», ammette Florina, «ma ho imparato subito perché avevo fretta di capire e dialogare. E ce l'ho fatta. L'ultima volta che sono tornata in Romania è stato tre anni fa, ma dopo pochi giorni avevo nostalgia di Lama. Io devo stare qui, questa ormai è la mia terra».
Ma non c'è solo l'Est nella storia recente di questo paese. Dolce Esperanza Moronta ha 62 anni e viene da Santo Domingo. E' arrivata che ne aveva 42. Madre di due figli di 26 e 25 anni, si è sposata a Palena, ma poi è rimasta vedova. «Mi sono trovata tanto bene», racconta Dolce, «e i miei figli hanno studiato. Non ho avuto problemi ad ambientarmi e mi sento come se fossi nata qui. Ho assistito alcuni anziani, ma ora sono senza lavoro e non guido: spero di trovare qualcosa perché è dura andare avanti».
Nel 1997 il Comune si era fatto finanziare dalla Regione la prima scuola di italiano per stranieri: 16 milioni di lire, un botto per quei tempi. «Quel corso serviva a conseguire il diploma di terza media e anche a fare numero nelle scuole», racconta Lodovico Laudadio, responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune, che ricorda le notti passate a fotocopiare i libri di testo per mandare nei plessi, all'indomani, i bambini appena arrivati dall'Est. «Nel 1991 abbiamo avuto una bimba romena, all'epoca extracomunitaria», continua Laudadio, «che poi è riuscita a laurearsi con 110 e lode: un bell'epilogo, vero? In paese c'era una casa famiglia pronta ad accogliere quanti fuggivano dal Kosovo. Ma non posso dimenticare quanti misero a disposizione le case pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Non è stato semplice, ma abbiamo lavorato sodo, in silenzio e in sinergia con le forze dell'ordine. E l'integrazione che si è creata con la popolazione locale parla da sola».
Già, "unità nella diversità", come vuole il motto dell'Unione europea la cui bandiera azzurra con le 12 stelle sventola dal balcone del municipio. Manca solo l'altoparlante che diffonde l'Inno alla gioia, la nona di Beethoven, a ricordare che in paese non c'è più distinzione tra autoctoni e stranieri. Ma non ce n'è bisogno. «Da oltre vent'anni abbiamo un'attenzione particolare per chi non è di qui», spiega il sindaco Antonino Amorosi, «Comune, Comunità montana, religiosi: tutti lavorano per questa gente. Oggi abbiamo operai, artigiani, badanti, studenti e alunni lamesi a tutti gli effetti. Tra l'altro, visto il calo demografico la loro presenza ci ha consentito di non chiudere le scuole. E la popolazione ha condiviso la presenza degli stranieri trovando vestiti e generi alimentari. E' un segnale alto di convivenza civile, è attenzione verso chi ha bisogno e di questo sono orgoglioso. I lamesi hanno un cuore immenso. Abbiamo creato anche un bonus per ogni neonato: 27.500 euro dati in cinque anni a 44 bambini. E ora stiamo ampliando gli aiuti a chi sottoscrive un mutuo per comprare o ristrutturare la casa: una mano simbolica, ma un motivo in più per risiedere a Lama».
Una storia, una infinità di storie in questo paese al primo posto nella provincia di Chieti per numero di stranieri: 129 su 1.407 abitanti, il 9% della popolazione. Prima ci sono i romeni, poi i serbi e quindi gli albanesi come Alfonso, arrivato a marzo del '91 con papà, mamma e sorella. «In Albania non si poteva più viveve per i disordini sociali», racconta Vollca Rrushhulli, 53 anni, madre di Alfonso, «ricordo lo sbarco a Brindisi e l'aiuto della Caritas, mio marito che acciaccava un po' d'italiano perché vedeva in tivù i canali italiani. Ma ricordo soprattutto padre Salvatore, frate del convento di Lama: è stato un papà, si è preso cura di noi e ci ha fatto restare. Sono passati 20 anni», continua Vollca, «e a Lama stiamo benissimo. Alfonso si è fidanzato; la sorella di 29 anni è parrucchiera sposata a Torricella Peligna con un meccanico; mio marito Shaban è operaio in Val di Sangro. Anch'io ho lavorato e ora sono nonna a tempo pieno con due nipoti. Abbiamo comprato la casa qui: la gente è accogliente e ho tante amiche. Tornando indietro rifarei la stessa scelta». Vollca si è talmente integrata che oltre a parlare il dialetto fa cucina solo locale: «sagne e fasciule, pallotte casce e ove, pizza e fojje», spiega «e pure la sfogliatella di Lama», il dolce napoletano con l'aggiunta di strutto, noci, marmellata di uve Montepulciano e di amarene, diventato la tipicità del paese. «Una bontà», conclude Vollca puntando l'indice della mano sulla guancia e avvitandolo con uno scatto.
Florina Ionescu Vasilica, invece, ha 31 anni e viene dalla Romania. E' stata prima a Palena e poi a Lama: otto anni in tutto. «Quando sono arrivata», spiega Florina, «ho fatto la badante per sei mesi, poi la baby-sitter. Mi sono trasferita a Lama e per sette anni ho lavorato come falegname. Qui ho incontrato gente brava e ospitale che mi ha aiutato nei momenti difficili. Non conoscevo mezza parola in italiano», ammette Florina, «ma ho imparato subito perché avevo fretta di capire e dialogare. E ce l'ho fatta. L'ultima volta che sono tornata in Romania è stato tre anni fa, ma dopo pochi giorni avevo nostalgia di Lama. Io devo stare qui, questa ormai è la mia terra».
Ma non c'è solo l'Est nella storia recente di questo paese. Dolce Esperanza Moronta ha 62 anni e viene da Santo Domingo. E' arrivata che ne aveva 42. Madre di due figli di 26 e 25 anni, si è sposata a Palena, ma poi è rimasta vedova. «Mi sono trovata tanto bene», racconta Dolce, «e i miei figli hanno studiato. Non ho avuto problemi ad ambientarmi e mi sento come se fossi nata qui. Ho assistito alcuni anziani, ma ora sono senza lavoro e non guido: spero di trovare qualcosa perché è dura andare avanti».
Nel 1997 il Comune si era fatto finanziare dalla Regione la prima scuola di italiano per stranieri: 16 milioni di lire, un botto per quei tempi. «Quel corso serviva a conseguire il diploma di terza media e anche a fare numero nelle scuole», racconta Lodovico Laudadio, responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune, che ricorda le notti passate a fotocopiare i libri di testo per mandare nei plessi, all'indomani, i bambini appena arrivati dall'Est. «Nel 1991 abbiamo avuto una bimba romena, all'epoca extracomunitaria», continua Laudadio, «che poi è riuscita a laurearsi con 110 e lode: un bell'epilogo, vero? In paese c'era una casa famiglia pronta ad accogliere quanti fuggivano dal Kosovo. Ma non posso dimenticare quanti misero a disposizione le case pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Non è stato semplice, ma abbiamo lavorato sodo, in silenzio e in sinergia con le forze dell'ordine. E l'integrazione che si è creata con la popolazione locale parla da sola».
Già, "unità nella diversità", come vuole il motto dell'Unione europea la cui bandiera azzurra con le 12 stelle sventola dal balcone del municipio. Manca solo l'altoparlante che diffonde l'Inno alla gioia, la nona di Beethoven, a ricordare che in paese non c'è più distinzione tra autoctoni e stranieri. Ma non ce n'è bisogno. «Da oltre vent'anni abbiamo un'attenzione particolare per chi non è di qui», spiega il sindaco Antonino Amorosi, «Comune, Comunità montana, religiosi: tutti lavorano per questa gente. Oggi abbiamo operai, artigiani, badanti, studenti e alunni lamesi a tutti gli effetti. Tra l'altro, visto il calo demografico la loro presenza ci ha consentito di non chiudere le scuole. E la popolazione ha condiviso la presenza degli stranieri trovando vestiti e generi alimentari. E' un segnale alto di convivenza civile, è attenzione verso chi ha bisogno e di questo sono orgoglioso. I lamesi hanno un cuore immenso. Abbiamo creato anche un bonus per ogni neonato: 27.500 euro dati in cinque anni a 44 bambini. E ora stiamo ampliando gli aiuti a chi sottoscrive un mutuo per comprare o ristrutturare la casa: una mano simbolica, ma un motivo in più per risiedere a Lama».
© RIPRODUZIONE RISERVATA