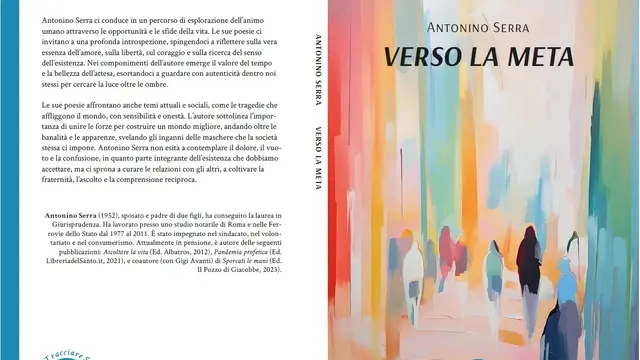Comunicato Stampa: “Storie di trine e di filet”: la genealogia femminile che ricuce memoria e futuro

Il libro “Storie di trine e di filet” , di Rosaria Anna Rita Zammataro ( Gruppo Albatros il Filo ), si apre su una panchina , in controluce. È lì che si raccolgono i giorni che passano, le parole non dette, le nascite che ridisegnano le case, i lutti che stringono i corridoi, il rumore dei porti e delle stazioni. Su quella panchina ci si siede per ascoltare il tempo e rammendare l’arazzo delle generazioni . La memoria prende posto, distende i nodi, rimette in ordine i nomi. C’è la responsabilità di tramandare, perché i racconti non vadano dispersi lungo la strada che unisce ciò che siamo stati a ciò che saremo.
L’opera di Zammataro mette in scena questo patto scegliendo una traccia matrilineare nitida e appoggiandosi a un prologo poetico che funge da diapason emotivo. L’autrice lo definisce “autobiografico con un pizzico di fantasia”, un racconto di donne vissute tra Malta, Riposto, Catania e Napoli, lungo un arco di tempo che va dal 1830 al 1951, quando la grande storia entra nelle cucine e nei salotti e lascia cicatrici profonde. La voce narrante dichiara la propria posizione: di queste vite ne ha conosciuta una sola, ascoltando le altre come fiabe serali, in un’epoca in cui la mitologia familiare passava dalla bocca all’orecchio e la scrittura si faceva casa comune. La finalità è esplicita: tenere vivo il ricordo, fortificare il filo sottile che unisce passato e futuro, condividere esempi di forza, dedizione, amore, cura.
L’architettura del volume è limpida e dichiarativa. Cinque capitoli, ciascuno dedicato a una protagonista . Maria apre il coro. La vediamo nello specchio di una mattina qualunque, con i gesti di sempre che raccontano una bellezza mediterranea ormai sfiorita, i capelli argento, i figli sparsi tra ritorni e partenze. I nomi di Antonina e Candida restano accanto, come due fuochi domestici, mentre gli altri percorrono traiettorie lontane. È un incipit che riassume un secolo in poche righe: la migrazione familiare, la fedeltà ai luoghi dell’infanzia, l’inevitabile dislocazione degli affetti. La voce cerca una misura di armonia e la trova nel prendersi cura, che diventa la prima lingua della genealogia .
Antonina subentra come perno. Il suo epiteto di “matriarca” indica una funzione più che un carattere. Da lei dipende l’equilibrio di una casa numerosa, l’amministrazione dei giorni, la gestione degli imprevisti. La narrazione non indulge nella mitizzazione del ruolo, ma mostra una capacità di mediazione che appartiene a molte donne del Sud in anni di trasformazioni istituzionali, di conflitti, di emigrazioni. La casa si fa snodo tra riti antichi e nuove esigenze del lavoro, tra relazioni parentali allargate e una idea di responsabilità che non delega. La famiglia è un organismo, la sua tenuta si misura nella continuità dei gesti.
Candida porta in dote la mobilità e la prova delle distanze . Napoli la affascina per dinamismo e possibilità, Catania diventa la sede degli affetti rimasti, Riposto resta lo sfondo di un passato che chiama. Il capitolo la segue nel tempo più felice, un mese che cambia lo sguardo, poi nel rientro e nella separazione affettiva. La solitudine si annida nelle pause quotidiane, eppure le figlie danno un nuovo ritmo ai giorni. Le partenze e i ritorni impongono una geografia sentimentale che culmina, infine, nella decisione di spostare l’intera famiglia per cercare un orizzonte più ampio.
Gemma affida alla dolcezza il proprio nome, senza precludere la complessità . La sua è una storia di prove superate con tenacia, con una rete di relazioni che la sostiene e con un’educazione sentimentale che valorizza il dialogo. Il suo capitolo non si allontana dal registro domestico, inserisce però il tema della malattia e della guarigione, del lavoro femminile come scelta di realizzazione, della casa come luogo di relazioni vive con ragazze e studentesse che passano per consigli e compiti.
Rita è la soglia . La sua voce arriva in una lettera datata 27 febbraio 1951 al fratello Saretto, una pagina che vibra di attesa e di gratitudine. Lì si definisce la missione di chi genera e accompagna, l’idea di una educazione alla dignità e alla coscienza, l’immagine dei figli come “membri dell’umanità”, senza retorica, con una fermezza serena. Il capitolo si chiude su un evento inaspettato e da quel momento la narrazione passa simbolicamente alla figlia, che entra in scena “comunque grata alla vita”. La scrittura diventa allora la forma della presenza possibile.
Questa coralità femminile non si consuma nel privato. Il libro stabilisce coordinate storiche chiare : fine del Regno delle Due Sicilie, Unità nazionale, due guerre mondiali. La vita delle protagoniste ne porta i segni, e li conduce dove la storia spesso non guarda, nelle pieghe di una quotidianità che regge l’urto degli eventi. Il libro mostra che la grande storia entra dalle porte di servizio e si siede a tavola con i familiari, insistendo sul modo in cui i cambiamenti si riflettono sui percorsi di studio e lavoro, sulla definizione dei ruoli, sulle migrazioni interne ed esterne. Il Sud che appare in queste pagine non è cartolina, è un laboratorio di resilienze e di scelte.
La modernità del progetto nasce qui. La genealogia è intesa come risorsa identitaria in tempi di mobilità e frammentazione . Le cinque donne ricompongono una tavolozza di affetti e doveri che parla al presente: l’educazione alla responsabilità, la conciliazione tra desideri e vincoli, la dignità del lavoro femminile, la qualità delle alleanze tra donne all’interno e fuori dal perimetro familiare. La scrittura si presenta come un atto politico nel senso più profondo, perché crea comunità, rende evidenti i legami, dà cittadinanza alla memoria. L’autrice dichiara l’intento di “fortificare quel sottile ma importante filo che unisce il passato al futuro”, dichiarazione che orienta anche il nostro modo di leggere.
Il lettore troverà in “Storie di trine e di filet” le risonanze di un canone caro a chi ama la narrativa familiare italiana. C’è un’aria di parentela con la coralità di “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg, per la centralità dei gesti e del parlato domestico. Si avverte la pressione del passato come in “La Storia” di Elsa Morante, che stringe le case e ne condiziona le traversie e si intravede la Sicilia di “La Mennulara” di Simonetta Agnello Hornby, nella misura in cui il Sud diventa teatro di energie e passaggi. L’originalità del libro di Zammataro si colloca nella linearità fedele del suo racconto e nel suo scopo dichiarato: affidare a una figlia e a molte figlie possibili il racconto delle madri .
Sullo sfondo resta l’idea di amore come alleanza civile. Le pagine conclusive lo dicono con chiarezza: l’Amore con la A maiuscola nutre i legami tra coniugi, genitori e figli, nonni e nipoti. Il libro esplicita questa tesi senza imposizioni, presentando cinque esistenze che hanno attraversato rischi, attraversamenti, perdite, e che hanno trovato la forza di rialzare il capo e offrire un sorriso. L’amore assume il volto della dedizione e della responsabilità, compone uno spartito variato di tonalità e contrappunti, definisce una grammatica di comunità.
Qui si colloca la pertinenza contemporanea dell’opera. La nostra epoca vive di connessioni veloci, di archivi liquidi, di memorie delegate a server anonimi. La genealogia femminile che abita questo libro ricorda che l’archivio più efficace resta nelle parole condivise , nelle lettere custodite, nei racconti ripetuti ai più giovani. La modernità non coincide con l’oblio. La modernità coincide con la responsabilità di fare spazio ai racconti che fondano.
La genealogia raccontata da Rosaria Anna Rita Zammataro non è una successione polverosa di ritratti, bensì è un’arte del presente , un modo di guardare il domani con gli occhi di chi ci ha insegnato a tenere il filo. Lì si comprende la posta in gioco: se il ricordo resta vivo, la storia non si perde, e la voce delle madri continua a insegnare come si attraversa il tempo.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK