L'economista Leon«Il sisma ha ridottoil valore della città»
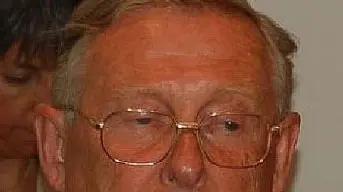
"Il terremoto ha rotto i rapporti economici. Chiuse le micro-imprese oltre agli studi professionali emigrati altrove. Le famiglie modificano lo standard di vita"
L'AQUILA. L'elenco dei danni. L'economista Paolo Leon, nel suo studio «Prime considerazioni sugli scenari di sviluppo e le strategie di intervento», partendo dall'assunto che è «impossibile» calcolare i danni del sisma, invita a tenere distinti quelli patrimoniali da quelli economici. «La perdita totale o parziale degli edifici, che rappresenta un danno patrimoniale, diventa almeno in parte anche un danno economico», scrive, «sia perché gli stessi edifici potevano essere utilizzati dagli imprenditori a garanzia di prestiti, sia perché la riduzione del valore del capitale immobiliare nei bilanci comporta una riduzione generalizzata del leverage (rapporto di indebitamento, ndr) e perciò della possibilità di finanziare l'attività economica. Inoltre, la distruzione parziale o totale di edifici storici porta con sé una riduzione del valore collettivo della città: che se non ha un immediato corrispettivo nel Pil, lo ha comunque nelle sue prospettive di crescita future, oltre che nell'identità del capoluogo e, perciò, della sua specificità. Questo aspetto ha un senso economico profondo perché ogni specificità locale rappresenta una forma di protezione non tariffaria (come ogni bene unico) che può costituire la base di reddito e di forme di rendita. Fra i danni non calcolabili va ascritta anche la rottura di rapporti economici tra soggetti, all'interno e con l'esterno del cratere.
In una situazione economica locale di declino ed una nazionale di stagnazione, ogni rapporto contrattuale interrotto determina una perdita definitiva di reddito e di avviamento. Non bisogna dimenticare che, nelle difficoltà indotte dal sisma, le famiglie hanno dovuto inevitabilmente ridurre lo standard di vita e ciò, di nuovo, genera una riduzione della domanda complessiva e perciò del valore aggiunto prodotto nel cratere. Contemporaneamente, l'importazione di beni e servizi cresce rispetto al passato sostituendo produzioni non più attive, e ciò avrà un'influenza sulle ricadute dei lavori di ricostruzione. Ciò che interessa maggiormente sono i danni economici di tipo permanente, causati dalla forzata chiusura di alcune attività che si è tradotta in una riduzione permanente del Valore aggiunto e dell'occupazione locale, almeno nel lungo periodo».
CASSA INTEGRAZIONE. «L'impressione è che il danno economico più rilevante sia quello ascrivibile alla chiusura di molte micro-attività imprenditoriali nel perimetro più tipicamente urbano del territorio colpito, mentre le imprese a carattere industriale, soprattutto di più grande dimensione, non sembrerebbero aver subìto danni tali da comportare una completa cessazione, ma al più interruzioni di carattere temporaneo. Quest'ultima affermazione sembrerebbe trovare conferma nei dati sulla cassa integrazione che, dopo aver registrato all'Aquila un'impennata nei mesi immediatamente successivi al terremoto, è tornata alla fine del 2009 su valori apparentemente più "normali", per poi seguire, dal febbraio 2010, l'andamento della cassa integrazione abruzzese, con un livello tuttavia inferiore, forse dovuto all'inizio dell'attività di ricostruzione».
I NUMERI. «Secondo stime della Confesercenti, all'interno dell'area urbana si contavano circa duemila imprese commerciali e del piccolo artigianato che sono state costrette a interrompere la propria attività, di cui circa 1500 localizzate nel solo capoluogo. Circa il 90% di queste imprese si ritiene abbia subìto danni tali da comportare la chiusura definitiva dell'attività o comunque un lungo periodo di inattività. Il volume d'affari sviluppato da queste attività imprenditoriali si stima potesse aggirarsi in media sui valori di poco superiori ai 300mila euro l'anno. Se si moltiplica questo dato per le 1800 imprese che presumibilmente hanno cessato definitivamente la propria attività si ottiene una stima del danno economico complessivo (ma limitato all'area urbana). La perdita di fatturato per gli operatori economici locali è quantificabile in circa 540 milioni, corrispondenti a una perdita di valore aggiunto superiore ai 200 milioni l'anno, che corrispondono all'11% circa del Valore aggiunto complessivo dell'area. Dal punto di vista occupazionale, i posti di lavoro che sarebbero andati perduti ammontano a oltre 3mila unità».
STUDI PROFESSIONALI. «La stima è probabilmente ottimistica», prosegue l'analisi del professor Leon, «perché nel centro storico e nei Comuni limitrofi non c'erano soltanto attività commerciali e artigianali. Fra le altre attività di servizio, particolare rilevanza assumevano soprattutto gli studi professionali (avvocati, commercialisti, studi di ingegneria) che, solo all'Aquila, si stima fossero più di mille. A questo riguardo, non è possibile sapere se una parte del lavoro professionale sia emigrata fuori dell'area del cratere, ovvero se professionisti esterni abbiano in qualche misura sostituito quelli locali. Infine, una perdita di reddito rilevante è quella legata agli studenti fuori sede. Si può ipotizzare che molti abbiano trovato nuove sistemazioni nel territorio, come dimostra l'elevato numero di iscritti 2010-2011, ma è certo che la distruzione degli edifici ha determinato una perdita di reddito per i loro proprietari, con una redistribuzione spaziale della rendita proveniente da tale attività».
(2-continua)
In una situazione economica locale di declino ed una nazionale di stagnazione, ogni rapporto contrattuale interrotto determina una perdita definitiva di reddito e di avviamento. Non bisogna dimenticare che, nelle difficoltà indotte dal sisma, le famiglie hanno dovuto inevitabilmente ridurre lo standard di vita e ciò, di nuovo, genera una riduzione della domanda complessiva e perciò del valore aggiunto prodotto nel cratere. Contemporaneamente, l'importazione di beni e servizi cresce rispetto al passato sostituendo produzioni non più attive, e ciò avrà un'influenza sulle ricadute dei lavori di ricostruzione. Ciò che interessa maggiormente sono i danni economici di tipo permanente, causati dalla forzata chiusura di alcune attività che si è tradotta in una riduzione permanente del Valore aggiunto e dell'occupazione locale, almeno nel lungo periodo».
CASSA INTEGRAZIONE. «L'impressione è che il danno economico più rilevante sia quello ascrivibile alla chiusura di molte micro-attività imprenditoriali nel perimetro più tipicamente urbano del territorio colpito, mentre le imprese a carattere industriale, soprattutto di più grande dimensione, non sembrerebbero aver subìto danni tali da comportare una completa cessazione, ma al più interruzioni di carattere temporaneo. Quest'ultima affermazione sembrerebbe trovare conferma nei dati sulla cassa integrazione che, dopo aver registrato all'Aquila un'impennata nei mesi immediatamente successivi al terremoto, è tornata alla fine del 2009 su valori apparentemente più "normali", per poi seguire, dal febbraio 2010, l'andamento della cassa integrazione abruzzese, con un livello tuttavia inferiore, forse dovuto all'inizio dell'attività di ricostruzione».
I NUMERI. «Secondo stime della Confesercenti, all'interno dell'area urbana si contavano circa duemila imprese commerciali e del piccolo artigianato che sono state costrette a interrompere la propria attività, di cui circa 1500 localizzate nel solo capoluogo. Circa il 90% di queste imprese si ritiene abbia subìto danni tali da comportare la chiusura definitiva dell'attività o comunque un lungo periodo di inattività. Il volume d'affari sviluppato da queste attività imprenditoriali si stima potesse aggirarsi in media sui valori di poco superiori ai 300mila euro l'anno. Se si moltiplica questo dato per le 1800 imprese che presumibilmente hanno cessato definitivamente la propria attività si ottiene una stima del danno economico complessivo (ma limitato all'area urbana). La perdita di fatturato per gli operatori economici locali è quantificabile in circa 540 milioni, corrispondenti a una perdita di valore aggiunto superiore ai 200 milioni l'anno, che corrispondono all'11% circa del Valore aggiunto complessivo dell'area. Dal punto di vista occupazionale, i posti di lavoro che sarebbero andati perduti ammontano a oltre 3mila unità».
STUDI PROFESSIONALI. «La stima è probabilmente ottimistica», prosegue l'analisi del professor Leon, «perché nel centro storico e nei Comuni limitrofi non c'erano soltanto attività commerciali e artigianali. Fra le altre attività di servizio, particolare rilevanza assumevano soprattutto gli studi professionali (avvocati, commercialisti, studi di ingegneria) che, solo all'Aquila, si stima fossero più di mille. A questo riguardo, non è possibile sapere se una parte del lavoro professionale sia emigrata fuori dell'area del cratere, ovvero se professionisti esterni abbiano in qualche misura sostituito quelli locali. Infine, una perdita di reddito rilevante è quella legata agli studenti fuori sede. Si può ipotizzare che molti abbiano trovato nuove sistemazioni nel territorio, come dimostra l'elevato numero di iscritti 2010-2011, ma è certo che la distruzione degli edifici ha determinato una perdita di reddito per i loro proprietari, con una redistribuzione spaziale della rendita proveniente da tale attività».
(2-continua)
© RIPRODUZIONE RISERVATA



